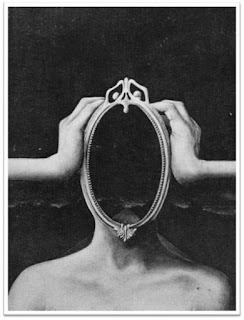Autrice:
Grazia Verasani
Editore:
Giunti – Scrittori
Numero
di pagine: 160
Prezzo:
€ 14,00
Il
mio voto: ★★★½
La
mia recensione: Una mattina, la radio passa una canzone d'altre
epoche. E le canzoni, così come i profumi, rievocano
sensazioni o persone. La protagonista ricorda d'un tratto l'amica
Dina: inseparabile, fino a una certa età, e poi improvvisamente
persa. Dimenticata, nel profondo, mai. Sappiamo poco della
narratrice: una che non si sbottona. Ha intrapreso da poco una
relazione clandestina con un musicista sposato, lavora senza troppa
voglia a un giallo: fa la scrittrice per mestiere, non fa nomi. I
luoghi asteriscati, le identità dei comprimari nascoste da una
lettera puntata. Non c'è spazio che per la migliore amica e i
ricordi. Quando erano compagne di banco agli antipodi – una
comunista e l'altra fascista, una povera e l'altra ricchissima –
ma, anziché accapigliarsi, si erano trovate. L'infanzia e
l'adolescenza passate vivendo come in simbiosi, poi il distacco.
Colpa dell'ordine naturale delle cose, crescendo, e del mal di vivere
di cui si ammala l'incostante Dina – prima a un passo dall'obesità
e poi magra come un chiodo, prima etero e poi omosessuale, prima
aspirante suicida e poi tossicomane. Sappiamo che Dina non c'è più.
Sappiamo che la protagonista, anonima, non le è stata accanto. E,
complice la radio, galeotta una maledettissima canzone, fa un
bilancio di episodi e responsabilità: un esame di coscienza a cuore
aperto. Quanto può dirsi responsabile per l'autodistruzione
dell'altra, abbandonata? Quando si sono separate, e
poi cos'è successo? Lettera a Dina è
un flusso di coscienza ordinato, intenso, interessante. Prima
volta tra me e Grazia Verasani, che emoziona con una
storia-confessione che ho immaginato personale, sentita. Il romanzo è
brevissimo: rapido, ma non del tutto indolore. Come quando qualcuno,
una sconosciuta per di più, ci rende parteci di una questione
privata, di un pezzo di vita che non era tenuta a svelarti, verso la
fine prevalgono il riconoscimento – grazie per le tante verità –
e la difficoltà – cosa rispondere, come mettere bocca. Allo stesso
modo, Lettera a Dina
posso consigliarlo, ma non so bene a chi. Con la sua scrittura sincera, la
ricostruzione en passant
degli
anni Settanta – mi ha fatto venire in mente La
ricchezza,
di Marco Montemarano –, l'antipatico espediente dei nomi censurati
e tutti i pregi, tutti i difetti, di quei romanzi che forse sono
stati più utili a chi li ha scritti che a chi li ha letti.
Autrice:
Gillian Flynn
Editore:
Rizzoli
Numero
di pagine: 85
Prezzo:
€ 12,00
Il
mio voto: ★★★
La
mia recensione: Che L'amore bugiardo sia stato un lampo di
genio isolato? Se lo chiedono un po' tutti, andando alla scoperta dei
primi romanzi di Gillian Flynn o leggendo le poche pagine dell'ultimo
pubblicato, Un buon presagio. Sono passati quattro anni dagli
straordinari drammi dei coniugi Dunne, ma l'apprezzatissima autrice
americana non ci dà indizi. Cosa fa? Scrive qualcosa di nuovo, nel
mentre, oppure no? Si inganna l'attesa rimarcando il mio fondato
dubbio e prendendosi del tempo da spendere con una narratrice
piacevolissima, ma coi suoi “ma”. Cartomante e ladra, la
protagonista arrotonda ospitando i clienti più vogliosi e ricchi nel
retrobottega. Con uno di loro, dopo l'orgasmo, scambia pareri sui
noir che legge, come fossero gli unici partecipanti di un improbabile
– e appiccicoso – club del libro. Ancora, c'è una cliente pavida
e ricca, che si è trasferita in una casa che scricchiola e che, nel
tardo Ottocento, fu protagonista di un orrido massacro. Una famiglia
sterminata dal primogenito, un quindicenne spietato e sociopatico: il
killer di due secoli fa somiglia in maniera preoccupante, per indole
e aspetto, a suo figlio Miles. Le tate scappano, gli animali vengono
mutilati, il sangue scorre sui muri. Coincidenze, o suggestioni
assassine? Tra la commedia nera e la ghost story, Un buon presagio
è intrigante, scorrevole, si
legge in un soffio. La protagonista, miserabile cartomante che fa
marchette all'ora di chiusura, abile nell'arte di cavarsela ma amante
delle letture di valore, è un personaggio grintoso, pieno, di quelli
che mi piacerebbe incrociare ancora. Qui, poi, c'è una Flynn
irresistibile, che sembra la nostra cara Alice Basso: linguacciuta,
sferzante, artefice di autentici pasticci – tra case stregate e
manipolazioni, professioni disoneste e etica professionale, generi
letterari agli antipodi che vanno curiosamente a braccetto. Ma,
grosso difetto, costa quanto un libro vero; l'autrice l'avrà scritto
in un paio d'ore, noi lo leggiamo in trenta minuti. Come la sua
protagonista, il racconto quindi è simpatico e vagamente
truffaldino. Farsi leggere la mano da una prostituta senza arte né
parte? Spendere dodici euro per una novella (benché pregevole) che,
al massimo, avrebbe potuto essere ospitata sul paginone centrale di
una rivista, con una sforbiciata vaga qui e lì?